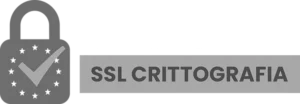“Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”. Il nome: eterna domanda senza risposta (“Chi sei?”), universale che si fa particolare, realtà che si trasfigura in essenza. La locuzione latina tratta dal De contemptu mundi di Bernardo di Cluny, che chiude il romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco – e contemporaneamente lo apre, dato che da essa si trae il titolo – è parimenti la chiusa dell’opera omonima che da tale romanzo prende il soggetto, nonché l’idea di fondo: una incessante, inevitabile, intrinseca ricerca.
Ricerca del nome, ricerca in musica, ricerca all’interno di un labirinto che non è (soltanto) luogo ma vero e proprio topos dell’eterno interrogarsi dell’uomo di fronte ai misteri della vita e della morte. Una morte che arriva, sistematica, geometrica, seguendo forme appuntite e scandite da segni che costruiscono una sottilissima drammaturgia di parole e forme, sottese ad una scena che del classico sviluppo drammaturgico ha ben poco.
Umberto Eco stesso scriveva, nelle postille al proprio romanzo, di averlo concepito come “un melodramma buffo con ampî recitativi e lunghe arie”; da questo assunto il compositore Francesco Filidei attinge per impostare la struttura stessa della narrazione, riprendendo l’originale suddivisione in sette giornate fissamente scandite dalle ore dell’ufficio monastico, e realizzando un tessuto finemente intrecciato di forme chiuse; queste ultime vengono concatenate fra loro in modo da formare una struttura solidissima sulla quale si innestano innumerevoli rimandi musicali interni ed esterni, leitmotive e citazioni che guardano alla grande tradizione operistica e sinfonica.
La struttura sinfonica, del resto, che è strettamente legata al lavoro di Eco (lo scrittore cita esplicitamente Mahler ), ritorna puntuale nella costruzione musicale di Filidei, che sviluppa un disegno simmetrico e speculare nella suddivisione dei due atti: ognuno è composto da dodici scene, come i dodici semitoni dell’ottava – a ciascun semitono (do, do#, re, mi♭, ecc.) è, infatti, affidata una scena, in senso ascendente, e quindi discendente, da do a do, in progressione cromatica: un cerchio che si chiude, un labirinto, una rosa di petali concentrici.
Il libretto, di Stefano Busellato e dello stesso Filidei, è l’ossatura della composizione, con la parola al centro di una drammaturgia in cui la staticità ed il movimento sono pesi e contrappesi sapientemente dosati, e che trovano nella regia, insieme spoglia ed immaginifica, di Damiano Michieletto la giusta, aderentissima traduzione. Il felice connubio con le scene di Paolo Fantin offre allo spettatore una scena sostanzialmente vuota, fatta di fondali neri – lucidi come gli specchi che spesso vi compaiono – sui quali ben risaltano gli elementi di un’iconografia medievale colorata e scintillante, a metà fra un affresco di Giotto dai colori vivissimi ed un quadro visionario di Hyeronimus Bosch. Un bestiario incantato di creature dipinte a tinte vivaci si anima, letteralmente, sotto i nostri occhi; la grande capolettera miniata prende vita sotto lo sguardo attonito del giovane Adso da Melk, in uno scriptorium che contiene, oltre agli innumerevoli tomi più autorevoli della tradizione, fra le fantasiose lettere del “mondo al contrario” decorate dal defunto amanuense Adelmo, un omaggio nascosto all’autore del romanzo (“una lettera E con tre lingue biforcute… […] uno spicchio di luna disegna una C […] una lettera O, ventre gonfio di un frate”: ECO!).
Sono numerosissimi i rimandi ad un mondo, quello medievale, appunto, fatto di carta ed inchiostro, di pietra, ma anche di fuoco, di carne e sangue; la scena di apertura, con il bassorilievo recante le sculture apocalittiche (i Quattro animali terribili, il Cristo Re, i ventiquattro vegliardi, il bestiario di Satana, l’Angelo, le sette trombe dell’Apocalisse) è un quadro memorabile in cui le statue si animano, rompendo la fissità del portale scolpito e danzando come anime dannate, deformi, e terribilmente, orrendamente vive, strette attorno ad un Adso insieme affascinato e sopraffatto dalla potente visione.
L’eclissi, altro simbolo tanto caro al Medioevo, è la perfetta nemesi di un sovrapporsi di luce e buio in cui ciò che è nascosto alla vista è in realtà svelato quando le pastoie della convenienza e delle false credenze vengono sciolte. Così, l’uomo del Medioevo non è tanto lontano dall’uomo contemporaneo, in una ricerca di sé che prescinde dall’unicità imposta, e che trova nell’arte e nell’espressione di una dimensione emotiva fortemente connotata la propria ragion d’essere.
Sulla scena, in alto, lontana, contornata da una doppia schiera di monaci assisi in coro – ieratici, pallidi volti che emergono dal buio (o dal nulla?) – sta fissa la Croce, contornata dalle spirali della Rosa, labirinto dalle linee nettissime di luce velate da lini impalpabili che cadranno, uno ad uno, inesorabilmente, nel finale, con lo svelamento del mistero delle morti nel monastero.
La balconata dei neri coristi, quasi celata allo sguardo, suggerisce inoltre una lettura de Il nome della rosa come oratorio ibrido, più che opera (o grand-opéra) in sé e per sé, il che ben si adatta alla struttura di cui si diceva sopra, priva di uno sviluppo autenticamente drammaturgico; d’altra parte, l’oratorio, genere per natura privo della parte visiva, si sostanza qui in una serie di scene che puntano sulla staticità più che sul divenire (le miniature, il bassorilievo, la biblioteca, lo scriptorium), oltre che su personaggi piuttosto fissi e privi di un percorso interiore.
Entro questi spesso asfittici confini Guglielmo da Baskerville si muove come un esperto Sherlock Holmes tra scorpioni, specchi deformanti, sigilli e libri proibiti, andando a scavare in una verità scomoda e mortale mentre, in parallelo, le autorità ecclesiastiche arrivate in pompa magna all’abbazia litigano fra loro e condannano innocenti al rogo a una velocità spaventosa.
Ogni monaco, ogni personaggio, grande o piccolo, è musicalmente connotato in maniera puntualissima, evocativa, immediatamente riconoscibile: il caratteristico ed espressivo declamato di Guglielmo da Baskerville, il pastiche linguistico e musicale di Salvatore, la geniale dodecafonia di Jorge da Burgos, il cantabile teso allo spasimo di Berengario, controtenore, i melismi giunti direttamente dal gregoriano che danzano e danno voce alla Statua della Vergine.
Oltre a ciò, madrigalismi ed effetti sonori di sorprendente vivezza illustrano, come in un compendio, le immagini via via evocate dal libretto, utilizzando, com’è abitudine di Filidei, gli oggetti più disparati accanto agli strumenti dell’orchestra: fogli di plexiglas, libri sbattuti l’uno contro l’altro, le pagine stesse degli spartiti, giocattoli, polistirolo “suonato” con l’archetto del violino; grazie alla resa mimetica possiamo “vedere”, ad esempio, il cavallo al galoppo, le cicale, perfino il diavolo, evocato con un breve assolo di chitarra elettrica distorta.
L’Orchestra del Teatro alla Scala, magistralmente guidata da Ingo Metzmacher, ci conduce con spavalderia ed un suono bellissimo e ben cesellato tra i meandri, è il caso di dirlo, del labirinto sonoro creato da Filidei. Sicurezza granitica, fraseggio cristallino, grazia leggiadra e potenza di impatto sono le tante facce di una macchina musicale rigorosissima ed efficace, priva di sbavature, che il direttore tedesco padroneggia dal primo all’ultimo rigo della partitura (che, diciamolo, conta quasi 900 pagine, oltre a pesare ben 15 chili come lui stesso fa notare!).
I “secoli bui” in cui si mescolano il terrore delle fiamme infernali, l’ignoranza e la sopraffazione, le regole ferree infrante senza nemmeno troppo nascondersi, l’ipocrisia della macchina ecclesiastica sono sulla scena contrasto stridente – ed efficacissimo – con gli splendidi costumi di Carla Teti, vivaci, policromi, scintillanti; le ottime luci di Fabio Barettin sanno evocare dal buio i particolari di un mondo in cui realtà, sogno, allucinazione si mescolano e si compenetrano dentro e fuori dalla scena.
Last but not least, le voci: una compagine varia e composita, con numerosi ruoli en travesti a spezzare la monotonia di colore di un universo, quello monastico, altrimenti esclusivamente maschile.
Lucas Meachem, baritono, è uno strepitoso ed acclamato Guglielmo da Baskerville: ad un perfetto phisyque du rôle si aggiunge un’espressività autenticamente teatrale, oltre ad una voce dal bel colore e dalla sicura emissione e ad un declamato che non scade mai nella monotonia, ma trova sfumature sempre nuove e convincenti.
Kate Lindsey è magnifica nei panni maschili di Adso da Melk, uno dei ruoli en travesti: la sua voce è argentina e ben modulata, e le sue movenze da ragazzo, l’ingenuo abbandono all’estasi dell’amore come ai tormenti delle visioni dal sapore infernale, vengono resi dal mezzosoprano statunitense con colori vivissimi ed efficacia espressiva, suscitando il meritato entusiasmo del pubblico.
Nel doppio ruolo della Ragazza del villaggio e Statua della Vergine il soprano Katrina Galka, che è in grado letteralmente di cinguettare come un usignolo e di prodursi in virtuosistici vocalizzi di coloratura, oltre che di mostrare un’elegante fraseggio ed un’intensa espressività. Il suo contraltare in scena è la bravissima ballerina Giada Vailati, che si ammanta della propria nudità intessendo un evocativo gioco visivo di Amor Sacro e Amor Profano.
Daniela Barcellona, irriconoscibile nei panni maschili di Bernardo Gui, inquisitore, disegna un personaggio dai tratti caratteristici con una timbrica variegata e lucente. Fabrizio Beggi interpreta con efficacia e bel timbro scuro Abbone da Fossanova, ruolo di basso buffo, severo ma con qualche crepa in cui si insinua una sottile vena di derisione, molto ben delineata.
Roberto Frontali, immenso, è un Salvatore di grandissimo carisma, efficacia interpretativa che non scade mai nel macchiettistico, perfetta padronanza della voce nonché della tutt’altro che facile parte; una delle prove meglio riuscite di tutta la serata.
Gianluca Buratto è un perfetto Jorge da Burgos, basso profondo; Giorgio Berrugi un inquietante e ben disegnato Remigio da Varagine, tenore; Carlo Vistoli, controtenore dalla grande raffinatezza timbrica ed espressiva, è più che all’altezza delle aspettative nei non comodi “panni” di Berengario, oltre che nel secondo ruolo di Adelmo da Otranto; Leonardo Cortellazzi, anch’egli impegnato in un doppio ruolo tenorile, risolve efficacemente sia la parte di Venanzio che quella di Giovanni Dalbena.
Completano con una validissima prova il cast i comprimari Ramtin Ghazavi (cardinal Bertrando), Alessandro Senes (Jean d’Anneaux), Cecilia Bernini (Ubertino da Casale), Flavio d’Ambra (Michele da Cesena), Adrien Marthonat (Un cuciniere/Girolamo di Caffa), che si segnala per il bellissimo timbro lucido e scuro e per la vivacità interpretativa.
Al Coro del Teatro alla Scala, sempre una garanzia, guidato da Alberto Malazzi, è affidata la voce di Adso anziano, mentre i Novizi sono interpretati dal Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, ben preparato da Bruno Casoni.
Successo ed applausi calorosi in un Teatro alla Scala da tutto esaurito, che non soltanto ha intrapreso spavaldamente la non facile missione di mettere in scena un’opera contemporanea nel tempio del belcanto, ma ne ha curato con efficacia, unita ad una narrazione fresca e convincente, la comunicazione, facendone un evento dai contorni irrinunciabili.