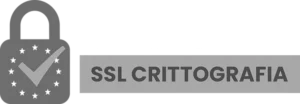Attila, potenza d’un nome che evoca devastanti orde di Unni provenienti dal più estremo e barbarico lembo orientale d’Asia, anche crudele vettore d’una mitologia istoriata d’orrore e paura: sovrano d’un popolo bramoso di distruzione e saccheggio, nomade da sempre, veloce nella mobilità degli accampamenti, senza mai discesa da cavallo e con favolistica cottura di carni tenute fra le cosce e il dorso dell’inseparabile equino. Ferocia barbarica d’un condottiero che rade al suolo Aquileia e dilaga con terrore fino alle porte di Roma. Per contro, Attila esaltato eroe nazionale ungherese, con orgoglioso conferimento del suo nome al battesimo dei primogeniti magiari. Nella visione europea occidentale, Attila è invece “flagellum Dei” e la sua potente figura storica ispirerà la tragedia Attila, König der Hunnen del drammaturgo tedesco Zacharias Werner, andata in scena nel 1808. Commissionata per il veneziano teatro La Fenice, da questa tragedia Giuseppe Verdi trarrà la sua nona opera, un dramma lirico in un prologo e tre atti. Il compositore pensò subito a Francesco Maria Piave come librettista, visto che avevano già proficuamente lavorato insieme per I due Foscari (1844) e per l’Ernani (1844). Non è ben chiaro perché, ad un certo punto della loro collaborazione, Verdi abbia preferito Temistocle Solera. In precedenza, grazie alla funzionale ed efficace versificazione di quest’ultimo, aveva composto la sua prima opera Oberto, Conte di San Bonifacio (1839), poi il Nabucco (1842), I lombardi alla prima crociata (1843) e la Giovanna d’Arco (1845). Salvo rivolgersi ancora a Piave nell’ultima stesura dell’Attila perché nel frattempo Solera era fuggito a Madrid inseguito dai molti creditori, quando i tempi del debutto dell’opera stavano diventando molto pressanti. Si parla, insomma, dei celeberrimi “anni di galera”: un incessante lavoro compositivo da sfinimento durante il quale Verdi, ancor prima di terminare un’opera, era costretto a firmare il contratto per la successiva. Alla prolissità narrativa del dramma Attila, König der Hunnen di Zacharias Werner, nel libretto vengono apportate considerevoli modifiche per rendere più comprensibile lo sviluppo del racconto attraverso semplificazioni della trama e riduzione del numero dei personaggi. Temistocle Solera non era soltanto poeta ma anche musicista, compositore, direttore d’orchestra: poteva quindi essere in sintonia con Verdi nel rapporto parola-musica. In più, Solera proveniva da una famiglia sensibile alla causa rivoluzionaria nazionale e connotata da un forte idealismo anti-assolutista, con tanto di padre militante contro l’Impero austriaco e prigioniero per lungo tempo nella fortezza dello Spielberg come Silvio Pellico. Non è quindi un caso che in tutti e cinque i libretti scritti per Verdi siano presenti, più che in altri, temi d’impegno patriottico ed elementi di propaganda risorgimentale. Al teatro La Fenice l’Attila andò in scena per la prima volta il 17 marzo 1846 e qui ritorna in un nuovo allestimento. Un’opera spesso ripresa per meritato orgoglio cittadino, visto che viene raccontata la mitica fondazione di Venezia: l’ultima messinscena, regista Daniele Abbado, risale al 2016 e la precedente al 2004, realizzata al PalaFenice al Tronchetto dal Laboratorio dell’Università IUAV.
Leo Muscato, nel suo solito stile registico che rifugge per nostra fortuna da ogni bislacca originalità, non trascendendo mai dall’assoluta centralità della partitura musicale, ambienta le vicende del re degli Unni in un unico spazio aperto, creato dalla scenografa Federica Parolini, e delimitato da alti e steccuti fusti di legno: una foresta immaginaria che il light designer Alessandro Verazzi modella con visionarietà di luci in ogni tonalità sabbiosa delle gradazioni di marrone. Tutta la pavimentazione è un gigantesco cretto color antracite che si sfrangia verso il proscenio, come un terreno reso secco e sterile da una guerra senza fine. Questo sarebbe bastato a materializzare la più desolata idea di distruzione, ma purtroppo la cangiante e multicolore retroilluminazione dal basso delle crepe finisce per trasformare tutto l’impiantito del cretto in una sorta di grande pedana da discoteca in stile Saturday night fever. La spaventosa devastazione bellica viene materializzata all’inizio in un vero incendio sullo sfondo, con fiamme talmente alte da inquietare ancora una volta tutto il pubblico su potenziali combustioni del teatro. Aquileia è rasa al suolo e brucia, la dilagante orda barbarica s’abbandona con furore allo sterminio della sua popolazione inerme, a saccheggi, a stupri… I monocromi costumi di Silvia Aymonino si rifanno a un’immaginifica Tartària per gli Unni e a una cenciosa derelizione per i profughi, mentre i protagonisti indossano abiti con colori meno spenti. Il tutto è però bloccato nelle più convenzionali disposizioni sceniche di coro e cantanti: prevedibili simmetrie, affiancamenti frontali alquanto distanziati, gestualità da manuale ottocentesco del genere Trattato dell’arte scenica di Serafino Torelli: in una tragedia dove il sangue gronda di continuo, nell’unico e brevissimo momento amoroso di tutta l’opera Oh, t’inebria nell’amplesso, / gioia immensa, indefinita!, Odabella e Foresto si mantengono ben lontani uno dall’altra come ai tempi del Covid. Ai cantanti non si richiedono di certo, come purtroppo impongono con protervia certi registi, triplici salti mortali con doppio avvitamento durante il canto, ma una presenza meno “fredda ed immobile come una statua” o perlomeno connotata da un più attoriale trasporto sarebbe stata forse più efficace.
Il direttore d’orchestra Sebastiano Rolli ha impostato una personale indagine interpretativa mettendo in evidenza l’impulso che Verdi imprime al rinnovamento del dramma musicale della prima metà dell’Ottocento. Lo si sente nella notturna ambientazione del prologo, con l’orchestra che fa risaltare la grande Notte Romantica, nume tutelare della Sragione ottocentesca, già discesa come un’ombra tetra in molte opere di Donizetti e Bellini: le tenebre sono calate dal Nord per impossessarsi dell’Italia e inghiottire il suolo sacro della patria, gli invasori stranieri hanno accecato la calda luce del Sud. Il direttore restituisce a tratti il cupo colore orchestrale di questa buia notte e il coro del Teatro La Fenice, diretto da Alfonso Caiani, fa risaltare il ruolo centrale che ha in quest’opera: all’inizio del prologo, Unni, Eruli e Ostrogoti rievocano con enfasi l’invasata e soverchiante atmosfera di guerra con Urli, rapine, / Gemiti, sangue, stupri, rovine, / E stragi e fuoco / D’Attila è gioco. Aquileia è distrutta e l’Italia pronta ad essere conquistata: un Eden in terra per l’insaziabile brama di possesso che giustifica la sete di violenza e le più orribili azioni belliche, precetto terribile che tragicamente accompagna anche la nostra contemporaneità. Nella seconda parte del prologo, eremiti che abitano un minuscolo arcipelago lagunare evocano insieme ai profughi fuggiti da Aquileia il chiarore di un’aurora dove la notte che inaugura l’opera svanisce come per antitesi nell’alba luminosa che chiude la scena: su queste isolette chiamate Rio Alto, oggi Rialto, la fondazione d’una città che il tenore Foresto, nonostante il luogo paludoso e inospitale, presagisce insieme al coro con un potente Ma dall’alghe di questi marosi, / qual risorta fenice novella, / rivivrai più superba, più bella / della terra, dell’onde stupor! Ecco vaticinata, proprio in quel posto desolato ma con un destino di gloria, la nascita della città più bella del mondo: Venezia. Inediti momenti del rinnovamento compositivo verdiano che, ad esempio, il direttore ci fa ascoltare appena prima dell’incontro di Attila con Papa Leone, nella contrapposizione tra il tracotante- berciare in 2/4 degli Unni Sia gloria a Wodan e il corale a cappella dei fedeli Vieni. Le menti visita, / spirito creator che pare un coro angelico nel Veni creator Spiritus: ecco, in questo divario melodico c’è già tutta la rivoluzionaria portata drammaturgica e musicale di Verdi. Oppure, nella conduzione del canto delle sacerdotesse alla fine del secondo atto che sembra il più parigino dei ballabili di Grand opéra e anticipa il coro delle schiave d’Amneris a inizio atto secondo d’Aida. In somma delle somme, un’apprezzabile conduzione orchestrale che presenta anche qualche finezza esecutiva, come negli espressivi rallentamenti nei da capo delle cabalette di Odabella e poi di Foresto.
Attila è il vilain di turno, il cattivo da odiare, ma anche un uomo fuori dal comune. Verdi infatti non crea il suo personaggio come crudele stereotipo del barbaro conquistatore ma lo caratterizza in modo sfaccettato: come Macbeth è ossessionato dal potere, dal dominio sugli altri, e quest’insaziabile e lacerante assillo lo condurrà alla morte. Mentre compone l’opera ha a disposizione Ignazio Marini dall’agile voce scura e veemente e gli cuce addosso una parte che, in termini vocali e drammaturgici, aggiorna i futuri ruoli di basso, innovazione già iniziata con lo Zaccaria del Nabucco. Una cantabilità votata al più virile e genuino eroismo: uso soprattutto del registro centrale per favorire una declamazione duttile ed espressiva, una spinta all’acuto fino al fa, un tenere a bada certi vezzi ad effetto d’inabissamento nel registro grave. Michele Pertusi interpreta Attila da inossidabile veterano del ruolo, peraltro già cantato alla Fenice nel 2004 sotto la direzione di Marcello Viotti. Anche se si notano opacità nel registro acuto, il basso parmigiano ha nel tempo affinato la lezione del grande Samuel Ramey anni ’70-’90: la prima produzione verdiana non è prescindibile dalla tecnica belcantistica rossiniana e, non a caso, dal debutto come Assur in Semiramide nel 1992, Pertusi da decenni è diventato un apprezzato habitué del ROF pesarese. Fin dal primo ingresso, nell’impetuosa esortazione alle sue truppe Eroi levatevi! stia nella polvere / chi vinto muor, si sente subito la grana vocale della più autentica scuola italiana di canto, di chi è nato a Parma ed è stato ispirato in famiglia dall’amore per l’opera e dall’accesa passione cittadina per Giuseppe Verdi. Riconoscibile caratura vocale di queste terre verdiane, da Carlo Bergonzi a Luca Salsi: risoluta fedeltà alla partitura, dominio dell’estensione vocale, timbro personale e caldo, emissione naturale senza mai forzare, declamato dagli accenti che cercano di rifuggire ogni verismo tonitruante, passionalità espressiva con cantabilità che è puro abbandono di sé… Nella grande scena di Attila del primo atto che inizia col recitativo Uldino! Uldin! dopo lo spaventoso incubo notturno, si manifesta la poderosa portata innovativa del genio verdiano: Mentre gonfiarsi l’anima, il cantabile andante piuttosto mosso nella tradizionale forma lirica della romanza s’interrompe a metà nella rievocazione delle severe parole di monito del “veglio” Leone – Papa Leone Magno – apparso in sogno, per poi riprendere l’aria nel tempo di 6/8. Pertusi interpreta questa cupa frase – strabiliante novità compositiva d’un “corpo estraneo” incistato nell’aria – con la stessa terribilità dello spettro implacabile del Commendatore mozartiano e conclude con l’incalzante polonaise della cabaletta Oltre quel limite / ti attendo, o spettro! dove vuole dimostrare al suo schiavo bretone Uldino, ma soprattutto a se stesso, il riacquistato senno dai naufragi del suo vaneggiamento onirico. E nel quartetto conclusivo Non involarti, seguimi non indugia mai in debordanti effettismi nell’irosità del declamato, evidenziando piuttosto il composto stupore del sentirsi tradito da tutti che si conclude nel suo assassinio da parte del vindice soprano, con quel simil-Tu quoque, Brute, fili mi di Giulio Cesare cantato con un dolentissimo E tu pure, Odabella?: interpretazione che solo la levatura di un vero basso nobile riesce a restituire.
Nel duetto con Attila, il generale romano Ezio è salutato dal re degli Unni come altissimo guerriero e scudo di Roma e vanto: degno avversario, gli viene subito riconosciuta pubblicamente l’onorabilità e le virtù guerriere. In questo ruolo, il baritono bulgaro Vladimir Stoyanov presta ad Ezio una voce dal timbro scuro non particolarmente incantevole ma omogenea e dall’attento fraseggio sempre incisivo, anche se nel registro acuto tende a un suono vibrato che si apre in modo poco attraente. Il baritono sa comunque ben esaltare i momenti eroici ma anche l’ambiguità del personaggio: il suo ruolo è infatti d’ambasciatore romano dell’Imperatore Valentiniano – nonostante quest’ultimo sia per lui soltanto un imbelle giovine – ma, al contempo, ordisce un ambizioso e segreto complotto proponendo ad Attila la spartizione dell’impero: Sul trono d’Occidente / tutto sarà disperso / quand’io mi unisca a te. / Avrai tu l’universo, / resti l’Italia a me. Celebri versi che mandavano in visibilio i patrioti italiani con fragorose ovazioni e spesso anche tumulti nei teatri, come ci ha splendidamente raccontato Luchino Visconti nell’incipit del film Senso, stavolta sulle note Di quella pira di Manrico, peraltro girato proprio all’interno della Fenice di Venezia. Anche la grande scena di Ezio all’inizio del secondo atto Tregua è cogli Unni (…) Dagli immortali vertici (…) È gettata la mia sorte è interpretata da Stoyanov con un trasporto che non eccede mai in istrionismi vocali ma sempre nella misura d’un canto controllato ed espressivo.
Nella cavatina d’inizio, prima indistinguibile fra le italiche donne da bottino per stupro, Odabella ruba la scena al re degli Unni rivelandosi giovane e orgogliosa amazzone. È posseduta da un impeto terrorizzante che riverbera una straordinaria carica d’energia, mossa da Santo di patria indefinito amor. Per ogni soprano, attacco “a freddo” temibilissimo perché – irrazionale pulsione del sangue, slancio assoluto e vitale – la voce dev’essere tagliente e acuminata come una lama d’acciaio temprato. Ascoltata di recente in una (finalmente) grintosa e padrona del proprio destino Mimì al Carlo Felice di Genova e in un’intensa Suor Angelica al Verdi di Trieste, il ruolo di Odabella è affidato ad Anastasia Bartoli. Il soprano ha offerto al difficile ruolo, soprattutto in virtù di potenza vocale, il carisma scenico e l’impeto ardimentoso della sua natura d’indomabile virago. Seducente e grintosa come physique du rôle, nella seguente romanza Allor che i forti corrono – un andantino in tonalità di do maggiore accompagnato da accordi ripetuti – sfoggia un ragguardevole controllo dell’emissione e tecnica vocale, anche se nell’estremo registro acuto, ascoltabile pure in altri momenti dell’opera, il suono s’inasprisce e sembra perdere bellezza. Comunque, Attila rimane conquistato dalla vergine guerriera, le concede la sua spada e la Bartoli trasforma Odabella in una Giuditta vendicatrice nell’impervia cabaletta Da t’è questo or m’è concesso: un gioco sottile d’agilità di forza dove il canto si fa concitato, sottendendo quell’aura messianica con cui la musica di Verdi circonfonde l’urgente causa della libertà nazionale. All’inizio del primo atto, nel recitativo Liberamente or piangi seguito dall’aria Oh! nel fuggente nuvolo Anastasia Bartoli, grazie ad omogeneità e duttilità vocale, tramuta l’impetuoso canto di forza e coloratura del prologo, simile a quello dell’Abigaille del Nabucco, in un sospeso lirismo dal bel timbro morbido che sembra anticipare la Leonora de Il Trovatore. Voce corposa e piena, nel successivo duetto con l’amato Foresto, nel terzetto Che più s’indugia? e nel quartetto finale Non involarti, seguimi conferma la protagonistica statura d’apprezzabile soprano drammatico d’agilità.
Fra i quattro personaggi, Foresto è il più convenzionale: una sorta di antieroe votato al patetismo – tranne nella stretta Cara patria – sempre impegnato nel ribadire le proprie sfortune in lamentazioni da profugo affranto e da amante tradito. Antonio Poli è Foresto, presenza scenica di riguardo e voce dall’emissione nitida, di giovanile freschezza. Nella cavatina Qui, qui sostiamo! (…) Ella in poter del barbaro! (…) Cara patria, già madre e reina, ha la possibilità di sfoggiare il bel timbro chiaro e caldo da tenore squisitamente italiano che abbiamo imparato a conoscere nei ruoli verdiani del suo repertorio. Dall’incantevole registro centrale che gli permette un fraseggio molto espressivo e solitamente agile nella salita alle note più alte, ha stavolta mostrato in sovracuto una sorta di velatura dello squillo che non è da lui, visto che è considerato uno dei tenori nazionali con una delle voci più luminose.
Il tenore Andrea Schifauto ha eseguito un’accettabile interpretazione vocale e scenica del personaggio di Uldino, lo schiavo bretone di Attila. Il basso Francesco Milanese è riuscito a restituire la giusta autorevolezza a Leone, carismatico “veglio” romano, in realtà papa Leone Magno. Un ruolo fondamentale, nonostante la sua concentrata brevità, che sancisce una svolta fondamentale allo sviluppo drammaturgico dell’opera, come avviene in altri interventi d’apparente comprimariato dei bassi nelle opere verdiane: Monterone del Rigoletto, mirabile esempio fra tutti.