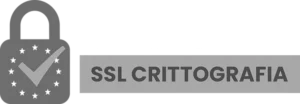Dopo più di vent’anni dalla sua riapertura, Attila è finalmente approdato al Teatro Real. Lo ha fatto, però, in forma di concerto, modalità che in questa casa è ormai diventata un marchio di fabbrica, con tutto il suo apparato abituale, in questa occasione ancor più accentuato (leggi, occhi incollati alla partitura e interpreti rigidi come baccalà), e con una frequenza allarmante che sembra giustificata dalla convinzione che “se non c’è messinscena, è perché il titolo non la merita”. O, almeno, è questo ciò che sembra pensare il signor Joan Matabosch nel confrontarsi con il Verdi “di galera”, dato che anche I lombardi alla prima crociata – questo luglio – e I masnadieri – nella prossima stagione – seguiranno lo stesso schema, mentre alla scena viene affidata l’ennesima Traviata. Il problema non è la versione da concerto (su questo stesso palco è stato dimostrato recentemente – mi viene in mente La Merope di Terradellas – che il formato concertante può funzionare alla perfezione se c’è energia teatrale in chi canta), bensì che, in questo caso, nemmeno da lontano è emerso quel vigore e quella incandescenza del primo Verdi, con un cast vocale povero di espressività e privo di tensione scenica, trasmettendo una inusitata sensazione di freddezza. L’omaggio alla leggendaria soprano galiziana Ángeles Gulín, nascosto in una riga discreta dello squallido foglietto distribuito, è parso un tributo modesto per colei che fu una delle grandi Odabelle del XX secolo.
Se si dovesse definire Attila con un solo aggettivo, questo sarebbe “incendiaria”, non per la ferocia del protagonista, bensì per la sua musica vibrante, poco sottile nella sua orchestrazione, in cui spicca in particolare la componente patriottica, così frequente nel primo Verdi. Attila è dunque una successione di numeri che risponde rigidamente alla convenzione teatrale dell’epoca, ma è costellata di cabalette virulente che invitano ad alzarsi in piedi e sguainare la spada, dove ogni numero è un highlight più memorabile del precedente; è un’opera di teatralità esplosiva che richiede cantanti senza paura e una bacchetta dal polso fermo.
Fortunatamente, quest’ultima l’abbiamo avuta. Abituati ai Verdi e Puccini da lui diretti con più pesantezza e mancanza di dettagli che slancio, oggi Nicola Luisotti ha optato per l’esatto contrario, il che è apprezzabile, premendo l’acceleratore fino in fondo, firmando probabilmente la versione di Attila più iperattiva della storia. Accanto a lui, Riccardo Muti – e non è poco –, noto per l’energia con cui affronta le partiture verdiane, sembrava una nonnina che guida a 30 all’ora in autostrada. In alcuni momenti, soprattutto durante la tempesta del prologo e nel finale secondo, precipitoso ma efficace, sembrava che fosse Speedy González in persona ad aver preso in mano la bacchetta. Non è mancata la tensione, con l’Orquesta Sinfónica de Madrid che ha risposto con precisione e impeto a ogni attacco; né l’ispirazione e l’immaginazione negli accompagnamenti monotoni che Verdi affida alle sezioni lente; né simpatiche licenze personali come la tendenza a legare gli accordi finali di ogni numero. In assenza di teatralità scenica, almeno c’è stata teatralità musicale, e già questo è mezzo trionfo.
Da parte sua, il Coro Intermezzo, diretto da José Luis Basso, ha offerto – come d’abitudine – una prova solida, purtroppo un po’ offuscata dall’effetto assordante della cassa acustica, ma con una sezione maschile sonora e potente nei cori guerrieri e una femminile impeccabile in “Chi dona luce al cor?” ed eterea in “Entra fra i plausi, o vergine”.
I tempi migliori di Sondra Radvanovsky, tanto celebrata in questo teatro, sono ormai passati, e la sua partecipazione in queste recite lo conferma. Pur non potendo negare un’emissione generosa, oltre che esperienza, intenzione e impegno, tutto questo non basta a coprire l’enorme esigenza tecnica richiesta dal personaggio. Odabella è, senza dubbio, uno dei ruoli più ardui del Verdi “di galera”, al pari di Abigaille. La sua scena d’ingresso, “Allor che i forti corrono” – un esercizio di pirotecnica vocale e salti intervallari micidiali – è stata macchiata da un vibrato fuori controllo, timbro acido e acuti sforzati. Ancora più discutibile è stato il suo “Oh! nel fuggente nuvolo”, un vero calvario vocale dove, malgrado le buone intenzioni nel fraseggio, i filati si sono frantumati, con alcuni suoni più vicini a uno starnazzio che a un pianissimo. Detto ciò, è stata l’unica del cast capace di infondere un minimo di credibilità al suo personaggio. Va anche riconosciuto che la sua prestazione è migliorata sensibilmente con il progredire della recita, assestandosi vocalmente nei pezzi d’insieme e riservando alcune delle sue carte migliori per l’ultimo atto. Nonostante ciò, non è sfuggita a qualche fischio isolato durante i saluti finali.
All’interno di un cast diseguale, l’Attila di Christian Van Horn è stato, vocalmente, il più convincente. La sua voce non è la più nobile né la più rotonda del panorama basso attuale, ma ha mostrato una certa solidità e un fraseggio ordinato. Sono mancate l’italianità e l’oscurità che Attila richiede, ma la sua interpretazione non è mai caduta nella rudezza. Michael Fabiano è stato un Foresto dai mezzi irregolari: canta sempre con ardore, il centro della sua voce può risultare gradevole, ma il fraseggio si impantana pericolosamente nella monotonia, e gli acuti lasciano intravedere un’emissione aperta. Inoltre, Artur Ruciński ha cantato con buon gusto ed esibito un legato curato, ma il suo timbro – per momenti, come ha dimostrato nella corretta cabaletta “È gettata la mia sorte”, completamente sovrastato dall’orchestra, posta nella buca – manca della mordacità e dell’aggressività verdiana che la parte di Ezio richiede.
Tra i comprimari, ha brillato di luce propria l’Uldino di Moisés Marín, comprimario di lusso a Madrid, mentre fuori dai nostri confini affronta ruoli di grande spessore, come Pirro nell’Ermione rossiniana. Invece, Insung Sim è stato un papa Leone I anemico, senza profilo né imponenza, lontano dall’autorità che dovrebbe ispirare un sommo pontefice capace di fermare nientemeno che Attila. Torniamo sempre allo stesso punto: che senso ha far venire appositamente un cantante straniero per un ruolo la cui parte vocale dura solo pochi secondi, e per di più con questo risultato?